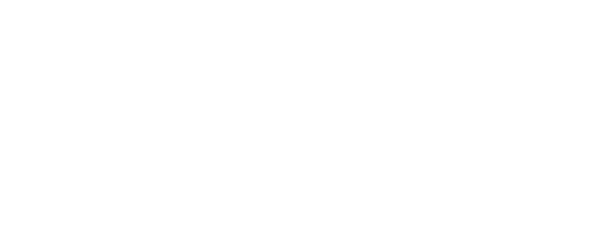Bambini con la valigia: la tutela della genitorialità si estende anche ai paesi extracomunitari
È quanto concluso dall’Avvocato generale della CGUE, il 23 febbraio, sul caso C-603/20 PPU (EU:C:2021:126) relativo ad un caso di international child abduction. La lite si basa sui ricorsi incrociati presentati da due conviventi indiani residenti in Inghilterra relativi alla figlia P. di circa tre anni, cittadina inglese, riportata dalla madre in India ed affidata alle cure della nonna materna, quando la donna era rientrata in Inghilterra. L’Alta Corte inglese, sez. famiglia, adita con separati ricorsi dai genitori (la madre per chiedere un cambio di giurisdizione relativamente alla minore ed il padre per ottenere il suo rimpatrio ed il diritto di visita) avendo dubbi se considerare o meno il comportamento della madre come un trasferimento (mancato rientro) illecito e, quindi, sull’applicabilità delle tutele previste da Bruxelles II bis (in primis quella del foro delle liti), stante l’abituale residenza di P. in paese terzo, ha sollevato una pregiudiziale per chiedere lumi alla CGUE cui l’AG ha proposto la soluzione in epigrafe.
Bruxelles II bis è opponibile anche ai paesi terzi. L’AG, richiamando la prassi costante della CGUE nota come la CGUE, in un analogo precedente (EU:C:2018:835 nella rassegna del 19/10/18 su di conflitto di competenza tra Inghilterra e Bangladesh), avesse evidenziato che il Regolamento 2201/2001 non stabilisce espressamente il suo ambito di applicazione territoriale: l’art.1 indica le materie cui si applica o meno, senza indicarne l’applicazione territoriale. L’art. 8 §.1 poi «stabilisce che i giudici di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale nei confronti di un minore se questi risiede abitualmente in tale Stato membro nel momento in cui il giudice viene adito e che nulla nel tenore letterale di tale disposizione indica che l’applicazione della regola generale di competenza in materia di responsabilità genitoriale da essa enunciata sia subordinata alla condizione dell’esistenza di un rapporto giuridico implicante più Stati membri».
Ergo «la regola di competenza generale prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 è suscettibile di trovare applicazione a liti che implicano rapporti tra i giudici di un solo Stato membro e quelli di un paese terzo, e non soltanto rapporti tra giudici di più Stati membri» (neretto, nda).
Alla stessa conclusione si può giungere anche analizzando l’art. 10 Bruxelles II bis che riconosce la giurisdizione sulle liti al giudice dello Stato membro ove il minore aveva la residenza immediatamente prima della sottrazione e/o mancata restituzione.
Irrilevanza della residenza abituale in uno Stato extracomunitario. In un lungo ed articolato excursus l’AG ribadisce la validità di questa tesi dimostrando come essa non sia inficiata dalla residenza del minore in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso presso un giudice comunitario (EU:C:2020:119 e 2014:2364).
In primis il minore che ha la cittadinanza europea, come nella fattispecie, gode di tutti i diritti riconosciuti dal diritto dell’UE, perciò da un lato il giudice dello Stato membro di cui ha la cittadinanza sarà competente a decidere tutte le questioni che lo riguardano finchè non ne acquisisce una di un altro Stato membro (si ha una sorta di perpetuatio fori) e dall’altro l’art. 20 TFUE riconosce a ciascun cittadino di uno Stato membro lo status di cittadino dell’UE ostando a tutte quelle decisioni interne che possano privarlo dei diritti discendenti da tale status (es. negare ad un genitore di un paese terzo con figlio cittadino dell’UE il permesso di soggiorno, di lavoro etc.).
Ciò trova conferma nelle necessità di tutelare il benessere del minore, considerato un interesse superiore e prevalente sugli altri confliggenti. Orbene Bruxelles II bis «ha lo scopo, nell’interesse superiore del minore, di permettere al giudice che gli è più vicino e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo, di adottare le decisioni necessarie».
Più precisamente, come emerge anche dagli studi preparatori a Bruxelles II bis, con l’art. 10 «il legislatore dell’Unione ha inteso tutelare l’interesse superiore del minore nel caso particolare di un trasferimento illecito o di un mancato rientro. La Corte ha così sottolineato che il regolamento medesimo mira a dissuadere dal commettere sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere che il ritorno del minore sia effettuato al più presto» (neretto, nda), sì che è irrilevante se il minore al momento dell’introduzione della lite in materia di responsabilità genitoriale avesse la residenza abituale in uno Stato extracomunitario.
Inoltre l’AG evidenzia che «qualora un minore sia stato sottratto e trasferito verso un paese terzo, non possono trovare applicazione la cooperazione e la fiducia reciproca previste dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, non vi è alcuna giustificazione per ammettere la competenza delle autorità giurisdizionali di tale Paese terzo, anche nel caso in cui il minore sottratto abbia acquisito la residenza abituale in quest’ultimo Paese» (neretto, nda). Se non fosse attribuita la giurisdizione al giudice dell’UE si snaturerebbe la ratio del Regolamento facendo venire meno detto effetto dissuasivo.