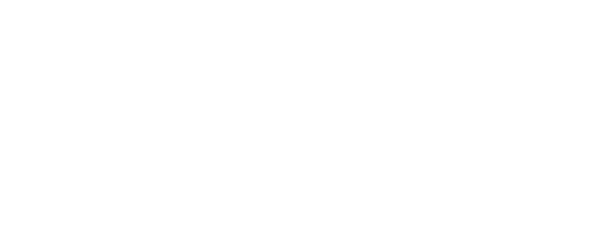Intelligenza artificiale e morte del processualista
Estendere i diritti è considerato meritorio per ogni operatore del diritto, se muta in rendita finisce a sfibrare le economie dell’etica comune ispirate da principi di responsabilità; qualcuno, poi, ha chiamato “dirittismo” l’idea che la qualità di una pretesa debba prevalere sulla sostenibilità del diritto – conterebbe prima il diritto, poi il dovere, e poi ancora una gestione oculata delle risorse poste a presidio del diritto -.
Ad esempio, il tempo – infatti, numerabile – nei processi civili: se non vi sono ragioni economiche o di opportunità che i processi durino poco – e le utilità connesse ad una celere definizione della vicenda sono poco sentite dall’utente – non vi sarà ragione per impedire la locupletazione di atti, udienze, procedure e la dilatazione dei tempi dell’accertamento civile: l’abbondanza non chiede freni, tanto meno limiti al tempo.
Oppure l’idea che la partecipazione di quanti più soggetti processuali garantisca meglio un risultato di una definizione celere della vicenda; che, insomma, il necessario intervento del giudice – o di un Collegio giudicante – celebri un risultato pratico e materiale parimenti ottenibile al di fuori di un processo, ovvero che dagli operatori legali non si possa prescindere per elaborare qualsiasi opera combinatoria di regolazioni giuridicamente rilevante.
La presa d’atto della scarsità del tempo – v. i tentativi di ridurre i tempi processuali -, delle risorse – v. la necessità di implementare sistemi efficienti di gestione degli affari giuridici e giudiziari – e l’insofferenza dell’utenza – richiedente una decisione nel più breve tempo possibile -, potrebbe imporre una diversa metrica professionale.
Non è un caso stiano proliferando soluzioni ingegneristiche del diritto straripanti il classico patrimonio di conoscenze e di abilità dell’avvocato e dell’operatore giuridico.
In breve, a far conto, di quanto si stia muovendo sotto pelle, quanto segue.
In primis, si stanno elaborando tentativi algoritmici – alias procedimenti sistematici di calcolo – di predizione degli esiti giudiziali – c.d. giustizia predittiva -; il che imporrà di affrontare più problematiche, in parte esulanti le tradizionali abilità dell’avvocato.
– La selezione dei metadati caratterizzanti un precedente giudiziale e causalmente rilevanti nella determinazione dell’esito finale – raccolti i quali si sarà in grado di fornire una predizione dell’esito giudiziale se ravvisati proprio quei metadati nella situazione concreta posta all’esame dell’avvocato -, i quali non coincidono necessariamente con gli elementi tipici di una fattispecie civile che l’avvocato combina/interpreta nel “qui ed ora” del manifestarsi della controversia.
La sistematizzazione complessa dei metadati da parte di banche dati e sistemi algoritmici – secondo ordini di successione temporale o casuale quanto più deterministici (al verificarsi di due fattori segue necessariamente un esito) – imporrebbe la continua investigazione di quanto algoritmicamente rilevante nella manifestazione del fatto e il professionista si fa, dunque, estrapolatore di dati, premonitore dell’esito giudiziale e riproduttore della programmazione di calcolo dei sistemi predittivi.
La sequenza non è più “fatto ® norma 1 e norma 2 e (…) ® proposta di soluzione giudiziale”, bensì “selezione dei metadati ® verifica della soluzione prevalente ® rischi ed opportunità della proposizione della soluzione alternativa”.
Il diritto applicato perde quell’enfasi miniaturista che pretende ogni caso diverso dall’altro e, di seguito, necessitante una soluzione giuridica dedicata e speciale; il numero diviene aggregatore di particelle atomiche/metadati – la cui migliore selezione costituisce l’operazione giuridicamente decisiva nella costruzione algoritmica – e la misura della rilevanza statistica – anche i programmi/format per redigere atti processuali dovranno quanto più agevolare l’individuazione dei metadati al sistema destinatario in modo di consentirne la riconoscibilità, come già ambito da un recente progetto dell’Avvocatura di Stato, secondo criteri di consequenzialità ed immediataspiegabilità -.
– L’avvocato sarà allora tanto predittivo – premessi i fatti, sarà in grado di predire l’esito – quanto elaboratore di soluzioni giuridiche le quali, per sconfessare un consolidato casistico, dovranno essere tanto più forti e sofisticate da sollecitare, sotto impulso giudiziale, la rivisitazione dei criteri programmatori interni ai sistemi di giustizia predittiva.
I possibili esiti giudiziali vengono generalmente anticipati alla sua maturazione – e, di seguito, l’utente della giustizia sarà in grado a carte già scoperte di parametrare rischi, opportunità, risorse finanziarie coltivabili per proposte alternative di esito giudiziale -.
– L’avvocato cioè dovrà necessariamente sviluppare sia abilità logiche di matrice prevalentemente analitico/giuridica – per la correlazione fra gli elementi di un fatto giuridico, secondo ordini di priorità o, all’opposto, di non rilevanza – sia abilità statistiche di raccolta e di lettura dei metadati rilevanti quel fatto – già eventualmente elaborati da banche dati o dai sistemi algoritmici –.
Ne segue che le componenti retoriche e del convincimento giudiziale – cioè di persuasione della bontà di una soluzione giuridica “qui ed ora” meglio applicabile – finiscono per perdere consistenza a fronte di una macchina calcolante non emotiva e, dunque, incapace di selezionare fattori decisionali privi di consistenza analitica ed impossibili da inserire nei programmi di calcolo.
Il che, a parere dello scrivente, non costituisce affatto un male, costituendo le possibilità combinatorie dei fattori di calcolo il “tutto ed il necessario” a consentire sia al professionista l’espressione di creatività ed abilità nel diritto – v. ad esempio, l’uso assolutamente recessivo nella pratica giudiziale che si fa delle disposizioni di cui all’art. 12 delle disposizioni prel. al Codice civile sull’interpretazione della norma di legge, in pratica riproduttiva dei fondamenti di logica proposizionale – che eventualmente al Giudice, nel caso intenda discostarsi dal consolidato combinatorio, di prospettare motivando soluzioni alternative.
In secundis, le ADR – che dal frammezzo processuale prescindono -, di cui il PNNR prevede un deciso rafforzamento e che consentono predizioni di tipo economico.
Si è già scritto in questa rivista (“Ci sono solo due forze che uniscono gli uomini: la paura e l’interesse”, anche in ADR, di F.G. Capitani) di un tentativo di elaborare una formula logico-matematica delle ADR in grado di individuare il punto in cui non conviene alle parti un conflitto processuale, mediante la combinazione di costi processuali – specificamente processuali e per la difesa legale -, costi non specificamente processuali del processo – ad esempio: il costo opportunità dell’impiego alternativo al processo delle risorse da impiegare -, sanzioni processuali per la soccombenza in giudizio e quantità di probabilità dell’esito vittorioso – usufruendo proprio del supporto della giustizia predittiva -.
Si rimanda a quella lettura.
Anche in tal caso, all’avvocato è demandato il compito di combinare moduli pratici ed utilitaristici – non squisitamente giuridici -, trovando un accordo nella misura in cui sia quantitativamente preferibile alle scelte processuali.
In tertiis, gli smart contract, cioè programmi per elaboratore che operano su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse – v. L. n. 12/2019 -.
Verificate alcune condizioni fra i contraenti che intendono condurre un rapporto contrattuale, seguono gli effetti – secondo logica c.d. “if, then”- eliminando frapposti, costi di transazione professionale e di accertamento – per intenderci, proprio l’operatore giuridico – e svalutando la sequela “”negoziazione”/”messa in mora”/”trattativa”/”eventuale giudizio” -; l’avvocato perde cioè la “specialità degli effetti” i quali possono essere anticipati e previsti in un linguaggio informatico e combinatorio con minor dispendio di risorse e maggior trasparenza per l’utenza.
Anche in tal caso, come per i sistemi predittivi, occorre standardizzare le procedure, sintetizzare gli elementi rilevanti – eliminate le impurità semantiche -.
Per concludere, dell’avvocato conoscitore del solo diritto (forse) si potrà sempre più fare a meno, o perché inutile alla soluzione della vicenda giuridicamente rilevante o perché non formato in abilità squisitamente logiche, matematiche e, di seguito, anche economiche.
Il labirinto kafkiano – metafora dell’operare nel diritto -, insomma, dovrà essere finalmente pensato come un lungo corridoio verso la luce, anziché anfratto ostile al cambiamento ed alla poliedricità dei saperi.