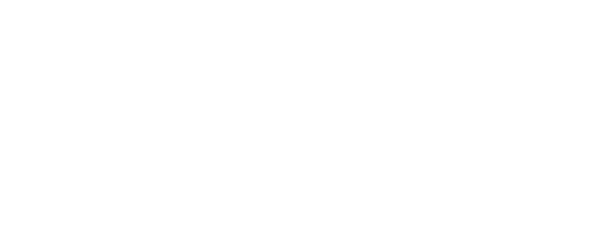Negare l’Olocausto significa abusare del diritto di espressione
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che la contestazione di crimini contro l’umanità si mostra come una delle forme più sottili di diffamazione razziale e di incitazione all’odio nei confronti degli ebrei. La negazione o la rivisitazione di simili fatti storici rimette in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l’antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l’ordine pubblico. Tali atti, pertanto, in quanto pregiudizievoli dei diritti altrui, sono incompatibili con la democrazia ed i diritti dell’uomo.
Il caso. Uno scrittore francese pubblicava, nel dicembre 1995, un libro con il quale tentava di dimostrare che gli ebrei non erano stati sistematicamente uccisi nei lager, che sarebbero stati campi di lavoro forzato e non di sterminio e che pertanto non vi era mai stata una volontà di genocidio da parte dei nazisti.
Tra il febbraio e il luglio 1996 numerose associazioni della comunità ebraica e organizzazioni per la difesa dei diritti umani depositavano cinque denunce penali con costituzione di parte civile nei confronti dello scrittore per contestazione di crimini contro l’umanità, istigazione alla discriminazione, all’odio, alla violenza e diffamazione razziale. I cinque procedimenti penali si concludevano con altrettante sentenze di condanna a reclusione e ammenda a carico dello scrittore. Nonostante le impugnazioni, le Corti superiori confermavano dette sentenze.
Lo scrittore proponeva ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) lamentando la violazione del proprio diritto alla libertà di espressione come garantito dall’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (la “Convenzione”), nonché l’abusiva applicazione dell’art. 17 della Convenzione medesima.
Gli articoli 10 e 17 della Convenzione. La CEDU ha precisato, in primo luogo, di non doversi pronunciare sugli elementi costitutivi dei reati di contestazione di crimini contro l’umanità, di diffamazione pubblica razziale o di istigazione all’odio razziale in diritto francese, spettando alle autorità nazionali interpretare ed applicare il diritto di riferimento. Compito della CEDU è infatti quello di verificare se, in punto di libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione, i tribunali nazionali competenti abbiano, in base al loro potere discrezionale, assunto decisioni fondate su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti. La CEDU ha ricordato al riguardo che la propria giurisprudenza ha sancito il carattere eminente ed essenziale della libertà di espressione in una società democratica, puntualizzando che: (I) al pari di ogni altra affermazione diretta contro i valori sottesi alla Convenzione, la giustificazione di una politica filo-nazista non può beneficiare della protezione dell’art. 10 della Convenzione; (II) esiste una categoria di fatti storici chiaramente accertati − quali l’Olocausto − la cui negazione o rivisitazione si vedrebbe sottrarre per effetto dell’art. 17, in punto di divieto di abuso di diritti, alla protezione dell’art. 10. In merito a quest’ultimo profilo, la CEDU ricorda che l’art. 17 della Convenzione ha lo scopo di impedire a qualsiasi soggetto di avvalersi delle disposizioni della Convenzione medesima per porre in essere atti tendenti a distruggere diritti e libertà ivi riconosciuti.
La disamina del contenuto dell’opera del ricorrente. Muovendo dai richiamati presupposti, la CEDU ha osservato che l’opera, all’origine delle condanne del ricorrente scrittore, analizzava in maniera puntuale numerosi avvenimenti storici relativi alla seconda guerra mondiale, quali la persecuzione degli ebrei da parte del regime nazista, l’Olocausto, il processo di Norimberga. Fondandosi su numerose citazioni e riferimenti, il ricorrente aveva rimesso in discussione la veridicità, la portata e la gravità di tali fatti storici, i quali tuttavia non potevano essere oggetto di dispute tra storici poiché, al contrario, chiaramente accertati. Ad avviso della CEDU, risultava chiaro come il ricorrente avesse rimesso in discussione sistematica i crimini contro l’umanità commessi dai nazisti nei confronti della comunità ebraica.
La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Osserva la CEDU che contestare la veridicità di fatti storici palesemente accertati, quali l’Olocausto, come ha fatto il ricorrente nella sua opera, non poteva in nessun modo essere ritenuto un lavoro di ricerca storica assimilabile ad una ricerca della verità. L’obiettivo e il risultato di un simile metodo sono totalmente diversi, perché si tratta in realtà di riabilitare il regime nazionalsocialista e, per conseguenza, accusare di falsificazione della storia le stesse vittime. Così, la contestazione di crimini contro l’umanità appare come una delle forme più sottili di diffamazione razziale nei confronti degli ebrei e di incitazione all’odio nei loro confronti. La negazione o la rivisitazione di simili fatti storici rimette in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l’antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l’ordine pubblico. Arrecando pregiudizio ai diritti altrui, tali atti sono incompatibili con la democrazia e i diritti dell’uomo e i loro autori mirano incontestabilmente ad obiettivi quali quelli proibiti dall’art. 17 della Convenzione.
La CEDU ha altresì rilevato che la maggior parte del contenuto e il tono generale dell’opera del ricorrente, e dunque il suo scopo, aveva una marcata natura negazionista contrastando quindi con i valori fondamentali della Convenzione, ossia la giustizia e la pace.
In conclusione, la CEDU ha ritenuto che ai sensi dell’17 della Convenzione il ricorrente non potesse avvalersi delle disposizioni dell’art. 10 della stessa utilizzando strumentalmente il suo diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione medesima poiché attinenti alla contestazione di crimini contro l’umanità; i predetti fini, se tollerati, contribuirebbero infatti alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione.
Cenni conclusivi: i delitti contro gli ebrei e la parola “razza”. La decisione annotata, sebbene risalente nel tempo, si eleva a presidio della tutela della memoria dell’Olocausto affrontando la delicata questione del c.d. negazionismo storico.
Come ricordato da Robert H. Jackson, nella sua veste di Rappresentante principale degli Stati Uniti d’America nel Collegio d’accusa del processo di Norimberga: «i delitti più feroci e numerosi che nazisti abbiano preparato e commesso furono quelli contro gli ebrei [..] La politica di persecuzione antisemita cominciò con misure non violente, come la privazione dei diritti politici, le restrizioni al culto e al commercio. Ben presto però passò allo stadio delle violente dimostrazioni di massa contro gli ebrei, dell’isolamento nei ghetti, della deportazione, del lavoro forzato, dell’affamamento e dello sterminio. Alla persecuzione parteciparono il governo, le organizzazioni del Partito, l’esercito, varie associazioni private o semi-pubbliche e masse di dimostranti “spontanei” che erano stati accuratamente istruiti e organizzati [..] Il programma di sterminio degli ebrei fu preparato con tanta cura che, nonostante la sconfitta della Germania, esso è stato in gran parte realizzato [..] La storia non ha mai registrato un delitto che abbia numerato tante vittime, e che sia stato commesso con così calcolata crudeltà» (JACKSON, Il Processo di Norimberga, Garzanti, 1948, pp. 99 e 100).
I principi scolpiti nella decisione CEDU in discorso si confermano quantomai attuali in un contesto sociale minato da numerosi episodi intollerabili ove anche l’utilizzo del linguaggio si mostra fuori controllo. In argomento è intervenuto di recente anche il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof. Paolo Grossi evidenziando, nella sua lectio magistralis agli studenti fiorentini, che: «la razza è un disvalore, è qualcosa contrario a un valore della società civile». Tuttavia, la parola “razza” non va cancellata dall’art. 3 della Costituzione «perché sono sicuro, e lo dimostrano i fatti che viviamo attualmente, che il razzismo non è finito, è ancora un vizio maledetto all’interno di parecchie comunità della Repubblica italiana: allora il termine, osceno e aberrante, deve essere lì come un lume acceso, perché in futuro non si debba incorrere in quelle vergogne in cui siamo incorso negli anni ’30 del secolo scorso» (cfr. ZULIANI, Il Tricolore? Un vessillo anti razzista, ne Il Corriere fiorentino, 8 gennaio 2020).