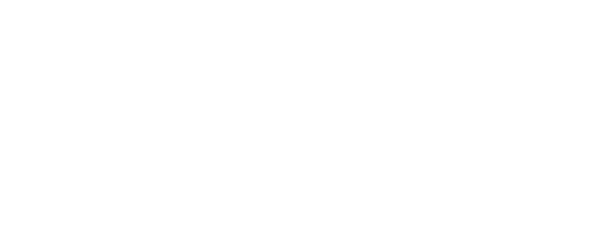Quando è lecito prevedere il requisito dell’appartenenza a una religione per lavorare nell’ambito di una Chiesa?
Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza resa alla causa C-414/16 del 17 aprile 2018 (ECLI:EU:C:2018:257).
Il caso trattato dalla Corte. La fattispecie vedeva l’Opera della Chiesa evangelica tedesca pubblicare un’offerta di lavoro per un progetto relativo alla stesura di una relazione sulla convenzione internazionale sull’eliminazione delle discriminazioni razziali. In tale offerta si richiedeva come requisiti sia l’appartenenza a una Chiesa evangelica o a una Chiesa rientrante nell’Associazione delle Chiese cristiane in Germania sia di indicare la confessione religiosa. Una cittadina non appartenente ad alcuna confessione ha avanzato la propria candidatura. Vedendosi negato il posto di lavoro, ritenendo che la candidatura fosse stata respinta per la mancata appartenenza ad una confessione religiosa, la cittadina ha fatto ricorso al Tribunale del lavoro, eccependo il divieto di discriminazione previsto dalla legge generale tedesca sulla parità di trattamento che recepisce la direttiva 2000/78.
La questione. La causa, in seguito all’appello dell’Opera della Chiesa evangelica, giungeva davanti alla Corte federale del lavoro che ha rinviato alla Corte di Giustizia la questione se la distinzione a seconda dell’appartenenza religiosa sia o meno lecita a seconda dell’interpretazione dell’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78 che è volta a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sulla religione o sulle convinzioni personali per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro, allo scopo di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento sancito dall’art. 21 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali – direttiva trasposta nella legge tedesca sulla parità di trattamento.
Il quadro normativo comunitario. L’art. 4 di tale direttiva consente agli Stati membri di stabilire che una differenza di trattamento basata su religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione nel caso in cui, «per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato». Pertanto, in forza del c.d. privilegio di autodeterminazione delle Chiese, sarebbe conforme al diritto comunitario una previsione legislativa che preveda una differenza di trattamento in base alla religione o alle convinzioni personali purché per la natura delle attività professionali o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali integrino un «requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione».
Non può demandarsi all’organizzazione religiosa il controllo dei requisiti. La Corte di Giustizia, in primo luogo, osserva che, in forza di un principio di coerenza e di ragionevolezza della norma, affinché quanto previsto dal citato art. 4 della direttiva conservi un significato, la verifica sul rispetto dei criteri previsti per ritenere legittima una differenza di trattamento su base confessionale non può essere demandato alla Chiesa o all’organizzazione che intende mettere in atto una differenza di trattamento, ma ad un’autorità indipendente.
La necessità di un controllo giurisdizionale effettivo. Secondo la Corte, l’art. 4 della direttiva 2000/78 mira ad assicurare un giusto equilibrio tra il diritto all’autonomia delle Chiese e delle altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, da un lato, e il diritto del lavoratore a non essere oggetto al momento della sua assunzione di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, dall’altro. Poiché tale bilanciamento deve effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa norma (ossia che la religione o le convinzioni personali costituiscano un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa) gli Stati membri devono sottoporre ad un controllo giurisdizionale effettivo il rispetto di tali criteri.
Come interpretare i requisiti che giustificano una disparità di trattamento? Infine la Corte di Giustizia fornisce le indicazioni ermeneutiche necessarie per accertare quando, in concreto, la religione o le convinzioni personali integrino un requisito essenziale. In primo luogo la legittimità di una differenza di trattamento è subordinata all’esistenza oggettivamente verificabile di un nesso diretto tra il requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa imposto dal datore di lavoro e l’attività in questione, derivante dalla natura di tale attività o dalle condizioni in cui tale attività deve essere espletata. Inoltre, il carattere «essenziale» del requisito deve essere interpretato, secondo la Corte, nel senso che l’appartenenza alla religione o l’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione deve apparire necessaria per l’affermazione di tale etica o l’esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia. In aggiunta, con la previsione del carattere «legittimo» del requisito relativo all’appartenenza alla religione si intende che tale appartenenza non deve essere piegata ad una finalità estranea all’etica della stessa Chiesa. Infine, il carattere «giustificato» del requisito, comporta che il controllo del rispetto dei criteri possa essere effettuato sia da un giudice nazionale sia dalla stessa Chiesa che ha previsto tale requisito, la quale deve provare che il presunto rischio di lesione per la sua etica o il suo diritto all’autonomia è probabile e serio, tanto da rendersi necessaria l’introduzione di un tale requisito discriminatorio.
Concludendo. In conclusione, secondo la Corte, l’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che, conformemente al principio di proporzionalità (quale principio generale del diritto comunitario), il requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per cui sia lecita la disparità di trattamento, deve essere costituito da un requisito necessario e oggettivamente dettato dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività professionale in questione, senza che possa comprendere considerazioni estranee all’etica della Chiesa.